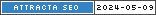Di Ascanio Celestini
Verso la fine degli anni Sessanta iniziava un decennio o poco più di impegno politico. Un impegno che nasceva nelle sezioni dove si stracciavano le tessere di partiti e sindacati sognando una politica nuova, un paese libero dai burocrati che erano passati indenni dal fascismo alla repubblica, dalla Democrazia Cristiana che doveva stare al potere per legge tanto da sembrare una monarchia.
Libero dallo sfruttamento sul lavoro, dalla scuola fatta di tanti banchi di contenzione rivolti verso una cattedra che era posta sulla pedana per far sembrare ancora più grande l’insegnante. Negli anni Settanta si sognava una scuola dove il sapere era condiviso e non versato dall’alto sugli scolaretti trasformati in vasi vuoti da riempire. Sono gli anni dello statuto dei lavoratori, quello che Mario Monti ha recentemente indicato come un ostacolo alla creazione di posti di lavoro, delle leggi sull’aborto e sul divorzio, fino alla 180 che ha iniziato una lenta, ma inesorabile chiusura dei manicomi-lager dove i pazienti erano così poco curati che venivano stipati per comportamento (agitati, semi-agitati, tranquilli) invece che per patologia e finivano dentro per ciò che avevano fatto (pericolosi per se o per gli altri e di pubblico scandalo) e non per ciò che soffrivano.
In quegli anni c’è stata una guerra che il potere ha combattuto con i tentati colpi di Stato e con i tanti morti nelle strade, con il sostegno alla criminalità organizzata che iniziava dall’occhio chiuso sulla speculazione edilizia alla vera e propria collusione, con il finanziamento della destra eversiva e con le stragi. E tanti hanno cominciato a pensare che il PCI non aveva il copyright sulla rivoluzione, che stava con tanti piedi in tante scarpe, nelle sezioni e nei salotti, nelle fabbriche e nei palazzi del potere. In quegli anni molti hanno pensato che il capitalismo non può essere riformato perché è un tumore. Quando il tumore trionfa, l’organismo muore. E dunque andava colpito prima che dilagasse. Migliaia furono arrestati. Arrestati in massa secondo il cosiddetto teorema Calogero «visto che non si riesce a prendere il pesce, bisogna prosciugare il mare». Si inventarono nuove galere e nuove tecniche di detenzione, istituiti i Kampi dell’Asinara o di Trani dove il detenuto era il camoscio in gabbia.
Davanti ai sequestri e agli attacchi al cuore dello stato si videro reazioni diverse. Moro restò solo. Mentre per Cirillo, dalle cui mani passavano i soldi della ricostruzione dopo il terremoto campano, corsero politici e industriali. Le porte delle carceri divennero girevoli e le trattative coinvolsero tutti: stato, anti-stato e para-stato. Poi l’utopia si sgretolò. Accadde un po’ alla volta o tutto insieme, ma fatto sta che ad un certo punto non stava più in piedi. Arrivò anche una grande nuvola di eroina e gli anni Ottanta furono i veri anni di piombo. Gli anni in cui si guardava tanto la televisione e poco dalla finestra.
Non era solo l’intrattenimento delle tv commerciali. Abbiamo assistito alla trasformazione della televisione. Prima era intesa come elettrodomestico, uno strumento che accendi quando decidi tu quando ne hai bisogno o quando ti fa piacere usarlo. Negli anni Ottanta è diventata essa stessa una finestra che puoi aprire o chiudere, ma sta sempre lì ad occupare una parte del muro. Sempre aperta. Magari col vetro chiuso, ma con la persiana spalancata. E se oltre la finestra succede qualcosa, ci butti un occhio. Con la differenza che attraverso la finestra vedi solo quello che accade veramente, mentre quello che ti mostra la televisione non sai più se sta succedendo davvero.
Non lo sai e non ti interessa saperlo. Linguisticamente non ha più senso nemmeno chiederselo. La notizia del telegiornale è messa accanto al balletto televisivo, condivide la musica della pubblicità, si mescola alle facce del comico e del politico. Si mescolano immagini e cose e si mischiano anche i canali. In quegli anni, guardare la televisione non significava più seguire un programma o vedersi un film. La televisione è rimasta nel suo buco, magari col vecchio centrino e la gondola che c’aveva messo sopra la nonna, ma un pezzo fondamentale di quell’elettrodomestico è comparso nella nostra mano. Il telecomando è stato una rivoluzione pari allo schermo che avevamo davanti.
Oggi la televisione si guarda così. Passando da un canale all’altro. Se prima era un frullato nel quale non capivamo più gli ingredienti perché erano tanti e con tutti i sapori, ora è un frullato di frullati. È come mettere insieme cibo e vestiti, mezzi di trasporto e parole di lingue straniere. Non viene fuori un cibo che puoi indossare o un treno parlante, ma una pappa incommestibile che non veste, non dice e non porta da nessuna parte. Il passo avanti può essere solo internet che ti porta in giro per il mondo lasciandoti in mutande davanti al computer. Come internet anche la televisione è dispensatrice di invisibilità. Vedere senza essere visti è meglio che spiare dal buco della serratura. Non rischi che qualcuno ti apra la porta all’improvviso o ti arrivi alle spalle e ti scopra. E poi ti dà l’idea di vivere davvero in una democrazia. Tutti ugualmente invisibili. Una repubblica di spettri. Quei proletari che potevano unirsi per spezzare la proprie catene si sono riciclati in fantasmi che trascinano le proprie catene. Insomma gli italiani si sono abituati male.
Potevano odiare i politici restando seduti in poltrona o, al massimo, potevano tirare fuori la testa commentando i titoli dei giornali al bar. Poi è arrivata la crisi. Non una guerra che distrugge le città con la bomba atomica che trasforma centomila esseri umani in un unico mucchio di polvere, ma un grande evento che coinvolge soprattutto i paesi ricchi.
Quelli poveri non corrono rischi. Sono già stabilmente messi male. Ma sono i paesi che hanno inventato l’unione europea che corrono rischi. Quelli che hanno creduto alla macchina magica del capitalismo, quelli che se la sono inventata e che l’hanno brevettata. Che l’hanno sperimentata attraverso dittature e colpi di stato. Sono gli spagnoli che dopo decenni di dittatura s’erano presi il diritto di avere almeno un altro boom economico. Uno con la dittatura e poi un altro con la democrazia.
Sempre con la stessa famiglia reale impermeabile a qualsiasi regime e a qualsiasi opposizione. Sono gli irlandesi che hanno provato le contraddizioni di una guerra di religione antica, moderna e post-moderna allo stesso tempo. Sono i portoghesi che hanno assistito al salazarismo che inneggiava all’ignoranza di conoscere solo dieci parole perché la cultura era nemica dello stato. È la Grecia dei colonnelli, ma anche l’Europa spaccata in due, divisa da muri e accordi, cucita e scucita da servizi segreti. Fino alla Romania delle bandiere bucate, passando dall’Ungheria del ’56, dalla Cecoslovacchia del ’68, fino alla Jugoslavia smembrata, torturata e bombardata. E poi è l’Italia metà giardino e metà galera che s’è svegliata nell’estate del 2001 a Genova. Sì, mi pare che il presente che ci appartiene e al quale apparteniamo ricominci da lì. Da quei giorni s’è capito meglio che il mondo globalizzato è una grande truffa. Globalizzazione è solo un altro nome dell’imperialismo. Prima erano le caravelle a muoversi verso le presunte Indie, ora sono le portaerei. I cattivi avevano la pelle rossa, ora hanno la pelle scura, ma non troppo e in genere hanno la kufiya in testa o il passamontagna nero, a seconda dei casi.
Dopo Genova, sia chi c’era, sia chi non c’era, ha capito che il ventesimo secolo era davvero finito. Finite le sue lotte in cerca di una classe sociale e un partito che desse la linea. Finite le rivoluzioni che portano il paradiso in terra. Finite le democrazie che si chiamano rappresentative come in un felice ossimoro. Ma se sono democrazie, cioè sistemi nei quali il popolo ha il potere, perché questo potere deve essere consegnato nelle mani di rappresentanti? Finita l’Europa e i blocchi. Finita la capacità dei mezzi di comunicazione di portare la verità degli eventi direttamente nelle nostre case attraverso il giornale o la televisione, attraverso la radio o la magica rete di internet. L’informazione si trasforma in narrazione. Nell’impossibilità di raccontare tutto, si racconta e basta. Si narra per essere affascinanti, per riempire lo stomaco al fruitore.
E se ti capita di stare veramente lì dove le cose succedono, ti accorgi che quella cosa non viene mai raccontata abbastanza bene. Non viene mai detto tutto.
Così nascono le nuove lotte. Dopo i partiti e i movimenti si torna ai territori dove la democrazia è diretta. Dove l’informazione non conta. Dove il partito è una nostalgia per nonni. Si arriva alla Val Susa che non ha rappresentanti. Ai No DalMolin di Vicenza che si riappropriano almeno di un pezzo di terra strappandola alla base militare americana per farne un parco della pace. Ai coordinamenti contro l’inceneritore di Albano, le discariche di Riano, il ponte sullo stretto (che finalmente è stato decretato ufficialmente una stupidata)… fino agli occupanti dell’ex-cinema Palazzo, del Valle, di Cinecittà, del teatro di Ostia. E a chi li rimprovera di dire sempre no risponde il poeta, codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Da Pubblico del 18 settembre 2012
http://pubblicogiornale.it/cultura-2/ascanio-celestini-chi-dice-no/